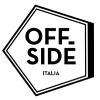di Jorge Pasculli – Rivista Túnel (novembre-dicembre 2020, edizione n. 37)
Traduzione di Andrea Meccia
1960. Non c’erano cellulari, internet, negozi, Playstation e Tv nella maggior parte delle case. Avevamo appena le matinée nei cinema di quartiere, le partite allo stadio o alla radio, i primi calci al pallone. Ma eravamo immensamente felici perché giocavamo tutto il giorno per strada, dove c’erano poche auto, in un quartiere dalla forte identità, dove ci conoscevamo tutti e frequentavamo le stesse scuole. Al punto che quando passavano i camioncini lanciando figurine alla rinfusa, noi ragazzini correvamo in gruppo lungo le strade, prendendo tutto quelle che potevamo come fossero caramelle.
Era il momento di massima felicità. Poi c’era il classico sfogliare la margherita: «Ce l’ho, non ce l’ho». Ci sarebbe costata fatica memorizzare la suddivisione di tutti quegli spazi rettangolari, ma avevamo le idee molto chiare su quali ci mancavano e quali erano i doppioni. Poi era il momento del «te la cambio». Si organizzava una bel mercato con i doppioni accumulati. Ognuno era un esperto in almeno uno dei giochi dove a far da moneta erano le figurine: il sapito o la destapadita, che consistevano nel mettere girate quelle su cui si scommetteva e tentare di capovolgerle con il palmo della mano incavato. Non serviva cospargere la mano di saliva né tantomeno ingrassare di colla il lato posteriore delle figurine. Chi riusciva a farle girare se le beccava tutte. C’era anche la arrimadita: le mettevamo tutte sul cordolo dei marciapiedi per poi spingerle verso il muro. Quello che la faceva avvicinare di più alla parete, faceva suo tutto il resto. E poi c’era la montadita, in cui, sempre dal marciapiede, si tirava verso la parete, cercando però di far cadere una figurina sulle altre. Se ci riuscivi, erano tue. Ovviamente le discussioni nascevano come quando si giocava con le biglie e “prendevamo le misure” per vedere chi avesse vinto. In verità, c’era qualcuno a cui interessava più mettere su una bisca che riempire l’album. Ma per un motivo o per un altro le figurine le lasciavamo solo in cambio di un «dai, facciamo una partita». Subito dopo, i capitani delle squadre si sfidavano in una specie di duello western per scegliere i propri compagni di squadra.

Un secolo e mezzo di figurine
Le figurine sono nate in Europa nel terzo scorcio del diciannovesimo secolo. Il tutto iniziò come forma di promozione di cioccolata e tabacco sui più svariati temi. Un’abitudine nuova, d’élite. Nel giro di poco tempo iniziarono a essere pubblicati lussuosi album da collezione. E spesso avevano un costo alto. I primi album sul calcio – insieme ai successi ottenuti dall’Uruguay nelle Olimpiadi del 1924, del 1928 e al Mondiale del 1930 – consolidarono un avido mercato, che si tramutò in una massiva vendita di album e figurine a prezzi popolari.
La sellada, la figurina vincente (e introvabile)
Fu sempre la più ricercata. La sua quantità variava in un album a seconda di quanti premi si mettevano in palio. C’era di tutto. Negli anni Quaranta, perfino l’ultimo modello di automobile. Allora c’era già il venditore ambulante. Il primo e più famoso si dice che avesse il suo posticino all’incrocio tra la Avenida 18 de julio e la calle Carlos Roxlo di Montevideo. Permutava e vendeva. A quanto pare, anche qualche sellada, qualche figurina vincente… Beccarne una era come ricevere una sorpresa il sei di gennaio. Eri l’idolo del quartiere. Una volta è capitato a me. Avevo già trovato delle stampe, dei poster, ma niente di importante. Fino a che non mi capitò Carlos Lucho Borges, ala sinistra della Celeste al Mondiale del 1954, più volte campione d’Uruguay con il Peñarol, primo campione d’America per club (la futura Copa Libertadores, N.d.R) nel 1960 e autore del primo gol della storia della competizione contro il Jorge Wilstermann allo stadio Centenario. Poi era passato al Racing di Avellaneda e allora stava per rientrare in patria per giocare nel Sud América di Montevideo. In uno dei suoi viaggi lungo il Río de la Plata visse l’indimenticato naufragio del piroscafo Vapor de la Carrera. Un evento terribile. Borges sopravvisse a quella tragedia e non l’ha mai dimenticata. Lasciato il calcio, iniziò a occuparsi del suo chiosco in Plaza Cagancha. Ero già grande quando gli raccontai la cosa. Lui, ormai uomo d’esperienza, mi guardava e sorrideva. Non poteva credere di essere stato, inconsapevolmente, il responsabile di tanta felicità per un bambino. Ero io quello che non ci poteva credere. Trovarmi di fronte a Lucho Borges… e raccontargli queste cose. Una cosa fortissima. È che tra l’altro mi mancava solo quella figurina per riempire la pagina. E sapete cosa ti davano in regalo? Un pallone di cuoio numero 5! Di cuoio, vero cuoio. Con camera d’aria per gonfiare e uno spinotto che bisognava infilare dentro dopo aver gonfiato. Dovevi metterci tanta forza perché spesso lo spinotto sporgeva che se ti davano una pallonata e la palla era anche bagnata…

«Con cinque calzini facemmo il pallone»
Ma era una cosa preziosa. Non ne avevamo mai avuta uno nel quartiere. Non è come oggi che ci sono mille palloni di tutti i colori e magliette dei campioni e dei migliori club del mondo. Adesso avevamo la pelota, ma ci mancava lo stemma sulle maglie. Così chiedemmo alle nostre madri che ci cucissero una striscia rossa in diagonale su di una maglietta bianca. Come quella del River argentino. Una cosa economica sì, ma di gran eleganza. L’unico peccato fu che non decidemmo prima da quale spalla dovesse partire la striscia. Ma allo stesso tempo ci sentivamo fortissimi. La palla del Lucho Borges diventò la mascotte del gruppo. Ci accompagnò “virilmente”, avrebbe detto Carlos Solé, in vittorie e sconfitte per un bel po’ di anni. La lucidavamo con grasso di vacca. Era marrone chiaro, bellissima. Avevamo camiseta e pelota. Ci sentivamo una squadra, come quelle di cui raccoglievamo le figurine. Ammirando tanti di quei giocatori, desiderando di giocare come loro. Imparando attraverso i racconti che qualcuno della famiglia ti faceva davanti ad ogni figurina. Racconti con cui crescemmo facendo nostra l’identità del fútbol uruguayo. Che bei momenti familiari. Il mio pallone, quello del Lucho Borges, giustificò per sempre la “utilità” di collezionare figurine. La cosa durò per un bel po’. Fino a quando il numero delle auto iniziò ad aumentare… Posso tornare a vedere ed ascoltare il suo ultimo colpo contro un camion che distribuiva latte mentre andava in direzione della nostra porta.
L’album come tesoro personale
Eravamo felici con poco. I compleanni e i Re Magi, punto. Babbo Natale non esisteva. Il Parco Rodò era la nostra Disneyland. Noi maschietti raccoglievamo gli album dedicati al calcio, nonostante ci fosse di tutto. A volte i genitori te ne compravano altri per vedere se memorizzavi anche gli animali, i presidenti o le invenzioni del secolo. Non avevano fortuna. Facevamo tesoro dei campioni del momento, quelli che uscivano sui giornali, nelle radio, di quelli di cui usavamo i nomi nelle nostre partite. Erano i nostri “Avengers”. E se anche si poteva giocare con il Cavaliere Solitario, Roy Rogers e Cheyenne, il pallone e le figurine erano le preferite. Alcuni di noi curavano gli album con meticolosità. Era il nostro tesoro e l’avremmo difendevamo fino alla morte. Sfogliavamo e sfogliavamo quelle pagine, avanti e indietro, una prima volta e poi un’altra ancora. Per incollare le nuove e osservare di nuovo tutte quelle che già avevamo. Per riguardare le nostre preferite. Incantati da quelle immagini che giorno dopo giorno uscivano dalla tasca di nostro padre quando tornava dal lavoro, dove le portava con sé per scambiarle con i suoi colleghi. Che allegria condividere quelle sorprese quotidiane con mi viejo! È uno dei ricordi più belli dell’infanzia. Mio padre non parlava tanto. Ma era di compagnia. Condividevamo il fascino per le figurine, il calcio, il Peñarol, Santa Teresa… È dalla mia adolescenza che mi fa compagnia da lassù, dal cielo.
Ognuno organizzava la sua “playstation”
Avevo cinque anni la prima volta che ricordo di essere andato allo stadio. Il berretto bianco di Domingo Pérez, rapido attaccante del Rampla che poi giocò nel River d’Argentina, Nacional e nella selección. Mi è rimasta quell’immagine di Domingo. Un tempo erano in tanti a giocare con il basco (Roberto Porta, el Vasco Pedro Cea, Severino Varela, Obdulio Varela spesso e volentieri), ma nel 1958 l’unico era Domingo Salvador Pérez. Giocò fino agli ottant’anni, ovunque potesse dare il calcio a un pallone. Un grande. Tanti i campioni che hanno giocato fino a tarda età: Schubert Gambetta, Julio Pérez, William Martínez, Walter Taibo, e tanti altri. Il fatto è che prima si giocava per pochi soldi ma con tanta passione. Obdulio diceva che in quella squadra che partecipò al mondiale del ‘50 l’unico davvero insostituibile era Julio Pérez. Correva per tutti, recuperava palloni, aveva un buon dribbling (lo chiamavano pata loca, gamba pazza) e dava “assistenza nel gol”, come per i due segnati nel Maracanazo. Un grande, in tutto e per tutto.

Quei clásicos
Il secondo ricordo è un clásico (Nacional vs Peñarol, N.d.R) a cui portammo mio nonno materno che aveva sempre vissuto in campagna e non sapeva niente di calcio. Eravamo tutta la grande famiglia, credo che fossimo in quindici. Diventò tifoso del Nacional perché lui era blanco, un elettore del Partido Nacional. Il calcio gli fece compagnia per tutta la vita dopo esser rimasto vedovo e costretto a vivere a Montevideo con le sue figlie. Era strano, non gridava: «Nacional!». Gridava: «Forza mis blancos!». Non si poteva parlare di calcio con il nonno, ma mi finanziava sempre per comprare figurine. Quel clásico fu la finale del 1959 che si giocò nel marzo del 1960 (la disorganizzazione non è un problema di oggi). La cosa diede modo a Washington Cataldi, gran dirigente del Peñarol, di riuscire a tesserare Alberto Spencer e Carlos Linazza (un ecuadoriano e un argentino) affinché potessero giocare. La partita terminò 2-0 con gol di Spencer e Linazza e vide scoppiare una rissa con i fiocchi. Mio padre era un lavoratore, ma a casa nostra circolavano tre giornali. Erano economici e ci piacevano tantissimo. Io divoravo la parte sul calcio. Per le tante domande e il tanto incamerare, imparai a leggere molte parole prima di andare a scuola. Riempii un bel po’ di quaderni dalla copertina rigida con ritagli di giornali e riviste. Divoravo le trasmissioni di calcio. Si giocava solo nei fine settimana e alla radio si parlava anche delle riserve. Sapevo a memoria tutti i riquadri degli album, panchinari compresi. Perché – inoltre – i giocatori rimanevano per anni nei loro club. Allo stesso tempo, da un anno all’altro, si vedevano poche differenze in ogni squadra. Per di più, non ridete per questo, con mio padre andavano sempre alla Tribuna Olímpica del Centenario cinque minuti prima che cominciasse la partita tra le squadre delle riserve. A poco a poco lo stadio si andava riempiendo. Quando c’erano 20.000 persone, si pensava che la gente non fosse andata. Da quando avevo cinque anni fino a quando ne avevo dodici, andammo sempre allo stadio. Andarci con mio padre era un giorno di festa. Tra le figurine, la radio, i giornali, si formò, per sempre, questo futbolero, questo appassionato di calcio. In mezzo a “gesta eroiche, a “imprese incredibili”, le nostre figurine sapevano ispirarci. Il mio album era il testimone fedele che tutto ciò era reale, era possibile. Ed era mio. Lo avevo fatto io.
Donald Campeón 1960
Secondo gli intenditori, è stato l’album più bello. L’azienda aveva già pubblicato nel 1953 e nel 1958 due album in cui ogni calciatore usciva accompagnato da un personaggio Disney, che lo rendeva doppiamente attrattivo: per via del calciatore e del disegnino. Ma, inoltre, avevi la possibilità di accorgerti se l’illustratore ci aveva indovinato, se la cosa funzionava. Imparavi a rendertene conto. Fu un album prezioso, come le figurine delle tre edizioni e degli album precedenti. Inoltre, tutte le buste di Donald Campeón (Paperino Campione) contenevano un waffle talmente buono che aumentava la voglia di collezionare quelle immagini. Lì compaiono i campioni sudamericani del 1959 imbattuti in Guayaquil, che batterono per 5 a 0 las caras sucias, le “facce sporche” argentine, campioni del 1958. In quell’anno, nel match di Buenos Aires Uruguay-Brasil, successe un pandemonio. I brasiliani avevano pugili mascherati da massaggiatori e fotografi. A William Martínez gli aprirono la testa sbattendola sul pavimento. Pepe Sasía mollò schiaffoni al punto che si beccò una sospensione di un anno. Aveva giocato molto bene in Argentina nel ’58. Il suo comportamento in quella rissa e le sue grandi prestazioni nel ’59 fecero sì che il Boca lo acquistasse dal Defensor Sporting per una cifra record. Con la percentuale che toccò al Pepe potè completare la sede del suo amato Club Ipiranga de Aires Puros, che era stato la sua casa durante l’infanzia, e ordinò dieci agnelli per festeggiare con il suo quartiere. El Pepe fu sempre così. Un anno dopo arrivò la grande vittoria, senza calciatori del Peñarol.

Quasi come soldatini
Tenerli tra le mani ti “dava la forza” delle loro storie, era come una trasfusione in cui ti “impossessavi” delle abilità di Cotorra Míguez, dei gol di ogni tipo accompagnati dal grido «la gente ya no come por ver a Walter Gómez/la gente non mangia per andare a vedere Walter Gómez», della forza e del coraggio di Gambeta; i colpi di testa a pelo d’erba di Matías Gonzalez, “il leone del Maracaná”. O ti sforzavi imitando l’abilità coraggiosa di Ciengramos Rodríguez; l’elegante portamento a testa alta di Jorge Manicera quando usciva palla al piede dall’area piccola. Ricordiamo un clásico del 1960. Ciengramos fece una giocata mondiale di fronte al lungo difensore brasiliano Salvador. Ciengramos era alto 1 metro e 53, Salvador 1 metro e 92. Ciengramos portò la palla fino alla bandierina del calcio d’angolo. Dietro di lui, senza perdere il controllo della sfera, stava il mulatto brasiliano. Chiuso in quell’angolo di campo, Ciengramos si arricciò su sé stesso e passò fra le gambe del brasiliano con tutta la palla.
Era un’altra epoca
Prima del venir meno di tutto lo “shopping del divertimento” che c’è oggi, le figurine ci hanno imbevuto di storie come quella di Eliseo Álvarez, centrocampista del Nacional che nel Mondiale del 1962 giocò infortunato tutto il secondo tempo perché non c’erano cambi. Poi morì giovane. O quella di Alcides Ghiggia, il più longevo dei campioni del Cinquanta, che morì un 16 di luglio (del 2015, 65 anni dopo il Maracanazo, N.d.R). O quella del Gallego Taibo, un portiere che fu campione con l’Uruguay, con il Nacional, con il Peñarol, che giocò superando i quarant’anni, ottenendo in modo eroico una promozione con il club Mar de Fondo dalla serie C alla B. O il caso del porteño Elio Montaño che giocò con Boca, Peñarol, Danubio e al Rosario Central in compagnia di César Menotti e Saía. Era un tipo che andava raccontando le giocate indemoniate che faceva. In un batter d’occhio lo buttavano a terra perché era un tantino presuntuoso. O Javier Patesko Ambrois, un bohémien incallito, un dieci che quando volle la fece finita con la nazionale, il Nacional, il Vasco, il Defensor. Come stile di gioco secondo molti assomigliava al grande Aníbal Ciocca. Tra i giocatori dallo stile rozzo c’era Ronald el Caballo Langón, calciatore di Rampla, Nacional, Defensor e della nazionale. Un nove grezzo, ma atletico che cercava la porta con potenza da tutti i lati. Non si intimidiva mai. I suoi tiri spesso andavano fuori ma lui continuava a provarci. Ora, se centravano la porta… Un po’ come Guillermo Chongo Escalada che giocò nel Nacional e nella nazionale. Corpulenta ala sinistra che aveva un cannone nel piede mancino e che attaccava come un treno. Nelle risse scoppiate nella selección lui e El Pepe facevano “spalla contro spalla”. «Era un’altra epoca», diceva El Pepe, un po’ mortificato e parlando da veterano. Vedete… Giocare in trasferta in Coppa Libertadores era un’impresa. Non c’era la Tv e non c’era il Var e i poliziotti (e gli arbitri) erano sempre molto casalinghi. Bisognava essere un po’ picchiatelli… per non aver paura in quei posti. O Loco completamente, come dicevano al porteño Navarro. Portiere, padre di Navarro Montoya. In Uruguay giocò con Rampla e Defensor. Era “pazzo” e stop. Aveva l’abitudine che quando bloccava una palla la faceva rimbalzare contro il palo e la raccoglieva in mezzo ai suoi avversari. La gente non sapeva se applaudirlo o ucciderlo. Però aveva una presa sicura. E si prendeva le sue responsabilità. Un “antesignano” del Loco Gatti. E del Loco Ortiz, che brillò nell’Atlético Mineiro e Wanderers negli anni Settanta. Con la sua lunga bionda aggressiva chioma e bermuda arrivava fino alla metà campo sfuggendo agli avversari. I bohémien allora avevano due veterani deliziosi: Mario Bergara e Julio Toja. Riempivano gli stadi della serie B. A proposito di riempire gli spalti in serie B, nel 1968, un anno speciale da molti punti di vista, l’Huracán Buceo fu protagonista di un gran fenomeno popolare. Scelsero Topo Gigio come mascotte e fu un successo, fu un successo la sua canzone, fu un successo il suo entusiasmo che contagiò emozionanti carovane di camion dove salivamo “per fare la storia”, cosa che giustificava il nostro marinare la scuola il sabato. El Hura era salito dalla serie C dopo un lungo percorso. Il suo campionato nella seconda serie generò tanta simpatia da avere sempre lo stadio pieno a ogni partita. Tifoseria e squadra si entusiasmavano l’uno con l’altro. E arrivò alla finale con il Bella Vista. Fu il 19 ottobre del 1968. Quel pomeriggio, tra l’altro al Centenario, davanti a 35.000 persone, il gran Ladislao Mazurkiewicz pose fine al record di imbattibilità di Aníbal Paz. Il gol lo segnò Ramón Silva che giocava ancora nel River. Lo stesso Ramón fece un autogol dopo un rimpallo e fu uno a uno. Di tutte queste storie ci riempivano le figurine. Modi di giocare, modi di vivere. Era un’altra epoca.
Addio all’infanzia?
Come accaduto a molti dopo essere cresciuti, dovetti distaccarmi dei miei amati giochi, tra quelli c’erano almeno sette album di figurine della mia infanzia. Bisognava trasferirsi da una casa grande a un piccolo appartamento e io «già frequentavo il liceo», cosa che mi servì per reclamare nuovi diritti. Ma sempre la nostalgia di quelle amate figurine non mi abbandonò. Un bel po’ di anni dopo (un venticinque anni credo) mi informai su come procurarsi album di figurine. C’è anche un piccolo mercato locale, collezionisti per passione e professionisti. Anche in giro nel mondo. La cosa più semplice è andare a Tristán Narvaja (il mercato della domenica di Montevideo, N.d.R) o visitare il sito Mercado Libre. C’è molta scelta perché, per fortuna, noi uruguagi collezioniamo di tutto. Chi mi ha dato tante istruzioni è stato Marcos Silvera Antúnez, ricercatore, collezionista, scrittore. Una volta siamo stati con Gregorio Pérez nella sua casa e non potevamo credere al numero di album che erano stati pubblicati nel corso della storia. Autore di vari libri su questi argomenti e de El álbum de figuritas/L’album delle figurine, dove si ripercorre la storia, mostrandone le copertine, di tutti gli album pubblicati nel nostro Paese. Ve lo raccomando.
E lì erano gli album di cui io avevo nostalgia. Da quel momento ho iniziato a cercarli e a ritrovarmi un poco alla volta con alcuni di loro, anche se ridotti in pezzettini. Ogni ritrovamento era un’emozione che non riuscivo a nascondere, cosa che ovviamente faceva lievitare il prezzo dell’antichità. Ma rappresentava l’incontro con un nuovo elemento del mio puzzle più prezioso. Chi può mercanteggiare in quel momento? Chi determina la “utilità” di un’emozione? Quella che condividevamo con il mio papà. Quella che condivido con i miei nipoti e le loro figurine di oggi. Il fascino di aprire insieme una nuova bustina.